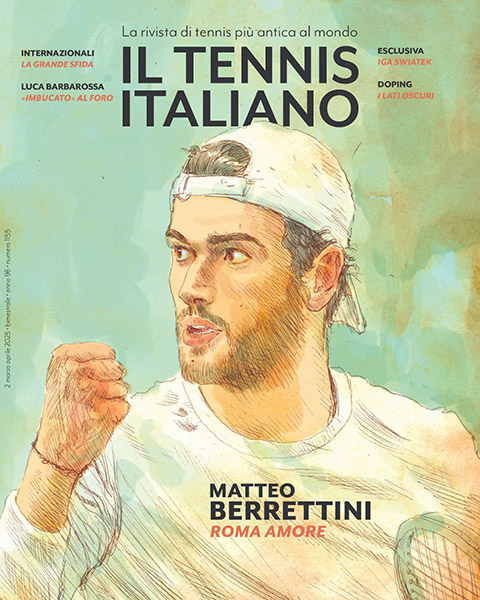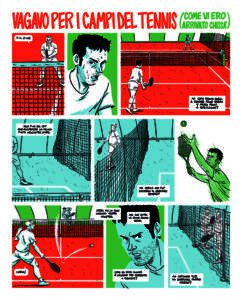In fondo, cos’altro è Monte Carlo se non una città immaginata, troppo pianificata per essere davvero vera, troppo furba per essere sincera. È un circuito, un casinò, un inventariato di ricchezza e riccanza, una fuga dal fisco, un campo da tennis fra il mare e il cielo. Adesso, è un posto dove è successo qualcosa. Fognini ha compiuto la sua storia. Ci ha tolto l’attesa per dare a tutti – a chi (per affetto) scarnificava di rimpianti una carriera già alimentata di successi e vittorie prestigiose e a chi (detrattori, talvolta aiutati nel compito ostile dallo stesso tennista) valutavano con cinismo ogni sconfitta – ma si diceva: a tutti ha dato un senso del giusto, delle proporzioni, della logica. Abbiamo dovuto spaventarci, noi appassionati e anche tifosi. E lui più di tutti. Ha avuto bisogno di impaurirsi, di temere di sentirsi respinto dal suo sport, dall’avanzare dei giovanotti (le sconfitte con Munar e Auger-Aliassime), e sentire il corpo rifiutare la fatica, i tendini bruciare, la caviglia dolere. Il tempo passare, la bella famiglia crescere, come un rifugio o come un più concreto senso del dovere, a seconda dei diritti o dei rovesci. E perdere così, per non averlo saputo trattenere con le vittorie, quel gesto così talentuoso che rende naturale l’esercizio difficile, e che manovra la palla e con essa gli avversari, per trovare poi conclusioni raffinate, alternando senza inciampo la potenza o il tocco, la sberla o la carezza. Scoprire, camminando sul baratro contro Rublev, il ragazzino che tira tutto forte, tutto a caso, tutto uguale, come se fosse un lavoro a cottimo invece che una ricerca di soluzioni, scoprire insomma a un solo punto dalla fine (sotto 4-6 e una manciata di occasioni per l’1-5) quanto invece sia esauribile la bellezza di questo sport e di questo mondo. Se il talento è un vampiro che succhia altre energie, la nostalgia è un sentimento che restituisce importanza a quello che resta.
Non era ancora finita, allora, ma serviva vedere la bellezza sparire verso l’orizzonte per poter fare un passo nella direzione giusta, e poi ancora un altro, contro Zverev, il superbo giovanotto nato campione; e ormai era una corsa libera, fino a riscoprire i limiti del più grande di tutti e di sempre su quel campo di terra macinata e pressata. Quel dritto spagnolo simile a una tromba d’aria, capace di soggiogare chiunque da tre lustri, e quel rovescio di Fabio, che riportava ordine allo scambio, e restituiva velocità alla palla, purezza al gioco. Nadal poi ammetterà di essere stato piccolo come mai in una lunga carriera: ma così insulso era stato ridotto dal gioco del nostro.
Eccola, la settimana attesa e mai stata, tanto da diventare un’utopia: struggente per i tifosi e irrisoria per gli accaniti e maldisposti. Quando chiesero allo scrittore uruguaiano come si potesse descrivere l’utopia, lui si servì dell’orizzonte: «Mi avvicino di due passi e lei si distanzia di due passi. Cammino dieci passi e l’orizzonte si allontana di dieci passi. Per tanto che io cammini, non la raggiungerò mai». A questo serve l’utopia: a camminare.